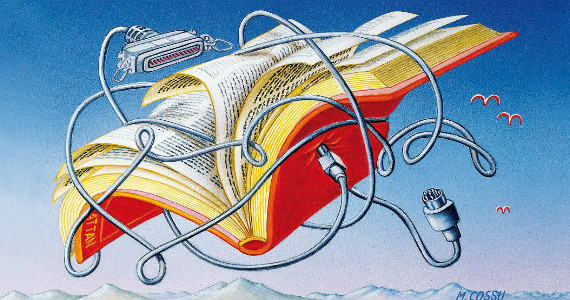I contenuti debbano esser compresi da tutti, devono arrivare ai visitatori. Spesso i nostri musei sono dei contenitori di oggetti, archivi di studio. Spazi che misurano la nostra ignoranza, la nostra frustrazione. Dove al limite vengono cercati “effetti speciali chiusi”, come ad esempio l’augmented reality a interattività programmata, che non lasciano spazio a uno scambio.
Un museo, una mostra, un articolo di giornale ha sempre e comunque un compito di base: condividere un sapere, avvicinare il pubblico a uno stato di conoscenza di ordine superiore. In altre parole: far sapere.
Ci sono due dibattiti in corso: uno sui linguaggi e uno sulla possibilità di partecipare alla costruzione dei contenuti, e alla loro diffusione.
Possiamo dire che sono due argomenti caratteristici della cultura digitale.
La questione è questa: cosa può fare un museo per aprirsi alle nuove richieste di un pubblico che chiede sempre più di partecipare e di capire. Gli approcci sono i più diversi e coinvolgono in generale tutte le nuove tecnologie di comunicazione che conosciamo da tempo.
Mar Dixon dice una cosa semplice: “fatelo e basta!”. E’ una risposta corretta. Non servono troppe parole.
Spesso l’ingresso nel digitale viene inteso semplicemente come una apertura a una tecnologia che non coinvolge i linguaggi ma sposta i contenuti su schermi a led. Peggio ancora, quando entrano nella rete, sono considerati semplicemente come canali di comunicazione.
Anche per i musei non è più questione del supporto di lettura – carta o tablet. E’ piuttosto capire il ruolo che deve assumere la comunicazione all’interno del percorso di lettura che coinvolge lo spazio e gli oggetti e i documenti esposti.
C’è tanta intelligenza intorno a noi. Ce la portiamo appresso. Leggiamo ogni giorno articoli su articoli su come utilizzarla, su cosa farne. Sperimentiamo quotidianamente nuove App, nuovi sistemi che ci permettono di coinvolgerci all’interno di stanze che riverberano il “sapere”.
Mar Dixon è uno dei capo fila per le questioni relative ai musei per il mondo anglosassone. Tende la mano ai curatori, ai progettisti, ai direttori museali. Non a caso è anglosassone: ha una visione pedagogica di chiarezza, democratica. Tutti devono capire, ne hanno il diritto.
Parte proprio dall’idea che i contenuti debbano esser compresi da tutti, devono arrivare ai visitatori. Spesso i nostri musei sono dei contenitori di oggetti, archivi di studio. Spazi che misurano la nostra ignoranza, la nostra frustrazione.
Conoscere tutto ciò che c’è da sapere è da secoli ormai cosa impossibile. Neppure il più capace degli enciclopedisti potrà mai conoscere tutto. Possiamo solo dotarci di dispositivi che ci permettono di arrivare a capire come conoscere.
Mar Dixon sta cercando di costruire un sistema dall’interno, un sistema di scatole concettuali che studiano e sperimentano soluzioni, suggeriscono metodologie. Suggerisce cose molto semplici: quello mai sbagliato di lasciare aperta una scelta, non imporre una tecnologia.
Questo sul fronte dei linguaggi e dei dispositivi. Questo però non esce da una dimensione pedagogica che va in una sola direzione: il museo che insegna, che espone il proprio racconto ma che non si pone nella condizione di scambiare ed eventualmente apprendere dal visitatore. Cosa potrebbe apprendere un museo? Ad esempio cosa cerca il pubblico, cosa vuole sapere, quali sono i contenuti dei quali ha bisogno in una società che usa più canali di comunicazione per fare circolare la propria cultura.
I musei e le mostre tendono giustamente a costruire la propria comunicazione sui livelli medio bassi di preparazione del proprio pubblico ma purtroppo si conformano a quel livello e non si aprono a livelli differenti.
Replicano questi modelli sulla rete senza offrire la possibilità di avere dialoghi di livello con un pubblico esperto.
Vengono cercati “effetti speciali chiusi”, come ad esempio l’augmented reality a interattività programmata, che non lasciano spazio a uno scambio. Si sono spostati i confini ma l’impermeabilitànon è stata ancora messa in discussione.
Non è quindi il problema di quale tecnologia utilizzare nelle sale e sul web, quanto la possibilità di scambiare contenuti di differente natura, di collegarsi con i propri contenuti a una rete ricca di essi. Il primo requisito di un museo che intende entrare nel digitale è appunto quello di appartenere al digitale: condividerne al suo interno i contenuti.
Un museo dovrebbe aderire a questa visione: essere promotore di elaborazioni delle immagini, non vietarne la riproduzione. Il museo dovrebbe essere la prima entità che mette a disposizione sul web tutti gli apparati visivi e i testi utili per la comprensione. Permettere la riproducibilità non a fini di lucro dei propri contenuti. Questa sarebbe la svolta digitale.
E’ quindi importante la condivisione su una rete allargata come quella del Web, tracciata dai sistemi di ricerca, prima che sistemi chiusi esclusivi, proprietari, sottoposti a diritti d’autore, sottratti alla condivisione.
In chiusura: quando mi trovo di fronte a cose che non conosco è ormai mia abitudine cercare un primo risultato sulla rete. Una parola, una immagine, un oggetto.
Leggo l’etichetta ma non mi basta. Guardo un contenuto video o audio ma riconosco sempre la stessa matrice educativa. Le dimensioni più immersive mi coinvolgono nei sensi ma fatte una volta sono ripetitive. Hanno una grande obsolescenza. E’ nella rete che la mia mente si ricollega con il tutto, la contemporanea camera delle meraviglie che lavora come un cabinet pedagogique! Come primo atto, il museo non deve accogliere il digitale in sé, attraverso tecnologie: deve entrare con i propri contenuti in questa dimensione. Il museo deve diventare parte delle reti, diventare un polo di raccolta, diffusione e discussione di contenuti in libera circolazione.
Ma stiamo ancora parlando di tecnologie e non ancora di una differente cultura museale legata al digitale capace di scambiare contenuti.
FONTE: Agenda Digitale (www.agendadigitale.eu)
AUTORE: Fabio Fornasari